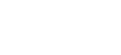Una vita in lotta: il cinema di Yilmaz Güney

“Forse, anziché girare un documentario, Huseyin Tabak avrebbe potuto realizzare un film d’azione”. Questo è stato il pensiero di gran parte dell’audience che, nella giornata di martedì 26 giugno, ha assistito alla proiezione – tenutasi nell’Auditorium DAMSlab – di The Legend of the Ugly King, omaggio filmico del regista tedesco di origine curda. Perché la vita di Yilmaz Güney, regista, attore, carcerato politico ed esiliato, ben lungi dall’essere una monotona sequela di informazioni e date, appare al cinefilo tanto avventurosa da divenire un oggetto incastonato nel mito. Una percezione, questa, non limitata agli spettatori delle sue pellicole, ma inserita profondamente nella cultura turca e curda, malgrado i tentativi censori delle autorità. Osservando con il dovuto distacco storico, nella biografia del regista di Yol l’impegno politico risulta inscindibile dall’esperienza dietro la macchina da presa: dunque sarà necessario ripercorrerli parallelamente, per provare a fornire un ritratto di una delle personalità più celebri e discusse della storia recente turca.
Come il suo biografo Tabak, Güney possedeva origini curde (da parte di madre): l’assenza di un aggregatore politico qual era e qual è il PKK (nato nel 1978, sei anni prima della morte del regista) non impedì al Re brutto – denominazione che prese per il suo fascino non convenzionale nello star-system anatolico – di trasporre il dramma della popolazione curda nelle sue opere. Ma l’analisi di Güney non partiva da basi squisitamente etniche: il principale interesse e motore attorno a cui egli gravitò furono le classi disagiate, il sottoproletariato urbano e agricolo. Non a caso, scelse come cognome fittizio una parola – güney, appunto – che riecheggiava le vite degli abitanti del sud della Turchia: quel sud che gli diede i natali, nei pressi della città di Adana. Proveniente da una famiglia di lavoratori di cotone, seppe trasporre i ricordi di un’infanzia nella miseria all’interno delle sue pellicole, denunciandone da regista l’inumano sfruttamento nei confronti degli ultimi della sua terra. Denunce che, assieme alle sue convinzioni comuniste, gli procurarono numerosi arresti: il primo dei quali, durato 19 mesi, fu causato da una frase contenuta nel suo romanzo Morirono con le teste chine. All’epoca, Güney rappresentava uno dei volti più noti del panorama attoriale turco, recitando parti che riecheggiavano figure gangster. Sei anni dopo l’arresto, nel 1968, con la fondazione della sua compagnia di produzione, Güney Filmcilik, iniziò il suo percorso da regista, inaugurato da Seyyit Han (La sposa della terra): seppur parzialmente riuscita – secondo il giudizio del suo creatore – la pellicola introduce la critica alla condizione femminile nella Turchia rurale, tratto distintivo della filmografia del re brutto. La lente dell’osservazione di Güney inquadrò spesso il mondo femminile, rappresentando la sua doppia subalternità, nei confronti dell’altro sesso e dei rapporti di classe; paradossalmente, malgrado la sua sensibilità filmica nei confronti del mondo delle donne, l’attore-regista fece storia per i suoi comportamenti isterici ed aggressivi verso la propria prima moglie, Nebahat Çehre. Al punto che, dopo aver subito un investimento automobilistico da parte del marito, l’attrice chiese e ottenne il divorzio.
Il 1970 vide l’uscita nelle sale di Umut (Speranza), incentrato sulle vicende di un vetturino con famiglia a carico, costantemente schiacciato tra la continua mancanza di clientela e l’aumentare dei suoi debiti, asfissiato da una famiglia in conflitto e da un amico incline alle passioni criminose. Ben evidente è la denuncia delle disparità sociali nelle città turche, enfatizzate dall’avanzare del progresso (rappresentato dal dualismo carrozze-taxi). Riprendendo suggestioni e focus di Ladri di biciclette e Accattone, l’autore utilizzò la sinossi del film per rappresentare le deviazioni di una speranza che, ben lontana dall’essere balsamo per l’esistenza o motore di un cambiamento, diveniva la causa della disfatta umana di una famiglia sospesa sull’orlo del collasso. Esemplare, in questo senso, l’ultima scena del lungometraggio, dove il concetto di speranza viene metaforizzato e personificato allo stesso tempo dalla corsa sfrenata di Güney, che – ormai troppo lontano dalla ragione – gira su sé stesso. Umut, parimenti alle altre opere, non sceglie la strada del patetismo nei confronti delle terribili condizioni in cui versano i personaggi, ma adotta una visione binaria, nella quale i sottoproletari vengono opposti a famiglie benestanti o a predicatori musulmani interessati ad alimentare speranze mortifere nel cuore del protagonista Cabbar. Non si tratta di una distinzione etica – assistiamo infatti quasi ad un elenco dei lati riprovevoli di Cabbar e famiglia – bensì fondata su un’ottica puramente sociopolitica: sono questi tratti a rendere il film uno degli spaccati più immediati e netti delle disparità di classe.
L’approccio socioanalitico del re brutto si ripeté nuovamente in un’altra pellicola, nella quale lo stesso regista avrebbe dovuto vestire gli abiti del protagonista, Cevher: Endise (Ansia) sposta l’attenzione dalle ombre notturne della città tentacolare agli sterminati campi della provincia meridionale, dove i lavoratori di cotone si trovano sottomessi sia al padrone che ai rapporti pre-capitalisti feudali. In tale situazione viene a trovarsi Cevher, costretto a far sposare la figlia per sanare una faida, ma impossibilitato ad accettare un’offerta troppo bassa, per questioni d’onore; allo stesso tempo, forzato a lavorare per pagare i propri debiti, rifiuta di aderire a qualsiasi mobilitazione contro lo sfruttamento, incarnando una sorta di Lulù (in salsa turca e fuori dalla fabbrica) senza possibilità di redenzione. Da questo punto di vista, si può scorgere un filo conduttore nella critica all’azione individuale, quando essa si presenta come scollegata dai rapporti solidaristici tra sfruttati.
Malauguratamente, Güney si trovò impossibilitato ad interpretare Cevher, dovendo subire un ulteriore arresto, per aver dato rifugio ad alcuni dissidenti anarchici; a tale condanna, si aggiunsero 19 anni di carcere, da scontare per aver sparato ad un giudice, Sefa Mutlu, che l’aveva provocato durante una cena. Scollegato dalle classi subalterne, da cui prendeva tutta la sua ispirazione per ridipingere il microcosmo turco, rinchiuso nell’isola di Imrali (la stessa che, decenni dopo, ospiterà la carcerazione di Ocalan), dovette sopportare anche la messa al bando delle sue opere filmiche, ordinata nel 1980 dalla nuova giunta militare. Rocambolescamente fuggito prima in Svizzera e poi in Francia, si nascose sotto falso nome per sfuggire ai servizi segreti turchi: al punto che la stessa figlia (all’epoca studentessa) finse di non conoscere il nome di quel regista turco che – come le disse l’insegnante – aveva appena trionfato al Festival di Cannes. Due anni dopo la Palma d’oro, sopraggiunse la morte, causata da un tumore allo stomaco. A distanza di trentasei anni, basta rivedere le immagini della vittoria di Cannes per avere un’idea della vitalità del cinema di Güney: oggetti d’analisi artistica e politica, i suoi film appaiono ancora oggi come uno sguardo sugli ultimi, spoglio di retorica, carico di denuncia.
Yannick Aiani