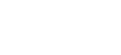Intimista, politico, contraddittorio, terapeutico: Il cinema secondo Marco Bellocchio

L’uscita in dvd della versione restaurata di I pugni in tasca (1965), lo sconvolgente esordio di un giovane italiano appena ventiseienne da Bobbio, provincia di Piacenza, offre l’occasione per questa Lezione di cinema condotta da Michel Ciment proprio con il regista del film (nonché presidente della Fondazione Cineteca): Marco Bellocchio.
Personalità spigolosa per questo autore che con le sue opere ha attraversato il cinema italiano degli ultimi cinquant’anni, con titoli come Nel nome del padre (1972), Buongiorno, notte (2003), Vincere (2009), fino al recentissimo Fai bei sogni (fresco di presentazione a Cannes). Tutti i suoi film, quale che sia il giudizio, non possono mai lasciare indifferenti.
C’è un segreto in questa longevità? “Non lo so”, si schernisce Bellocchio, “forse il fatto che abbia sempre creduto a quello che facevo. Lavorare su commissione è logorante per la fantasia”. Dunque l’impegno dedicato sempre alla realizzazione di progetti fortemente personali, nei quali la particolare sensibilità del regista potesse esprimersi liberamente. Una condizione irrinunciabile per mantenersi coerente nei confronti di se stesso e della propria arte: “Non credo sia giusto” – spiega – “attuare una scissione tra vita personale e attività professionale; ho sempre cercato una coerenza tra l’essere un cittadino e l’essere un artista”.
Per capire il cinema di Bellocchio è quindi fondamentale tenere presente la sua biografia. In particolare le due grandi influenze che dominarono gli anni dell’infanzia, dell’adolescenza e della prima gioventù: da una parte la rigida educazione religiosa, prima a Bobbio nella casa di famiglia e poi in collegio, una formazione culturale dai confini stringenti che definisce sia cattolica (la necessità di fare del bene e di essere onesti), sia protestante (priva cioè del perdono e della ricerca del compromesso); dall’altra parte il forte influsso della politica (nel partito marxista-leninista-maoista), che non fu mai però militanza dura e pura. Due influenze che si ritrovano in numerosi titoli della sua filmografia, due linee parallele che spesso si incrociano e collidono. Film come I pugni in tasca, Sorelle Mai (2006), Sangue del mio sangue (2015) sono fortemente autobiografici, mentre di respiro più ampio abbiamo titoli come Sbatti il mostro in prima pagina (1972) e L’ora di religione (2002). Ci sono sempre però queste due dimensioni, quella privata, intima (dove si avverte una forte componente psicanalitica) e quella pubblica, politica, che è in secondo piano perchè, per dirla con le parole del regista, “viene fuori da sola, quando vado nell’intimo di certi personaggi”.
Il punto di partenza è all’interno della casa, mai all’esterno. Anche in un film come Buongiorno, notte, che racconta la tragedia del sequestro e dell’uccisione di Aldo Moro, la dimensione domestica (i terroristi che cucinano e guardano la televisione) e quella onirica (il sogno di un’ipotetica liberazione fatto dalla brigatista Chiara), dominano su quella eminentemente storico-politica. Tanto che il film fu criticato, ricorda il suo autore, non solo dai politici, ma anche da un regista come Francesco Rosi, maestro del cinema di denuncia, che non condivideva questo punto di vista così personale e lontano dalla fedeltà storica. Bellocchio crede al contrario che l’infedeltà sia (entro certi limiti) obbligatoria, d’altronde “io divago dal sequestro, è vero, ma rimango sempre dentro la tragedia”.
Dopo questa relazione binaria, emerge durante l’incontro un’altra parola chiave: contraddizione. L’iniziale passione per la pittura viene lasciata cadere da Bellocchio per studiare recitazione al Centro Sperimentale di Roma, ma dopo un anno decide di dedicarsi agli studi di regia, dove l’interesse pittorico per le luci, i colori, la composizione dell’inquadratura, sarà fondamentale nella sua scelta: “ho rinunciato a fare l’attore perché avevo una voce sgradevole; ma sulla voce ci si può lavorare, come fece Gassman, io l’ho usata come una scusa”, e così il regista confessa il suo lato “oblomoviano” (e contradditorio ovviamente), perché accanto a una grande frenesia ci può essere anche la voglia per non fare troppo. Ancora, dopo il traumatico passaggio da Piacenza alla Capitale, Bellocchio si trasferisce a Londra, vissuta però “come se fossi a Bobbio”, mantenendo cioè una coesistenza tra lo slancio nel guardare al mondo avendo però dentro una dimensione da paese. Infatti, nonostante il fermento culturale londinese (“ma non andai a sentire i Beatles o i Rolling Stones”), l’autore scriverà lì la prima stesura di I pugni chiusi – storia ambientata nella provincia italiana più profonda e bigotta, con personaggi di un malsano nido familiare sull’orlo della follia – che verrà poi girato nella casa materna. Bellocchio definisce coraggiosa la scelta di trasferirsi nella capitale inglese, così come incosciente e rischioso fu il suo film d’esordio, allo stesso tempo non venivano mai meno le sue fragilità e debolezze, come le difficoltà nei rapporti umani, in un mix che riconosce come caratteristico non solo della sua vita personale, ma anche di quella artistica.
Ultima contraddizione, il rapporto più che complicato con la famiglia, portatrice in gioventù d’infelicità e sofferenza (e causa di un lungo percorso di psicoterapia individuale e collettiva): una vera “prigione sentimentale dalla quale volevo fuggire per essere libero di esprimermi, tante volte ho sognato di farlo, e poi, una volta fuori, ho ripensato con nostalgia alle case in cui ho abitato; una materia che la mia immaginazione prende e rielabora”.
Bellocchio racconta poi dei registi che l’hanno colpito maggiormente, anche se il suo stile personale non ha preso dirette ispirazioni da nessuno (“preferisco non appoggiarmi ai grandi del passato”): quando era un ragazzino, fuggendo finalmente dall’imposizione della sala parrocchiale della domenica, fu folgorato dal cinema americano, in particolare Elia Kazan con East of Eden (La valle dell’Eden, 1955), poi a Roma scoprì “la grande esperienza visiva dell’espressionismo tedesco di Lang e Murnau”, e si avvicinò ad autori come Robert Bresson e Michelangelo Antonioni, dei quali apprezzava la direzione degli attori, e poi il rigore stilistico del primo e “l’essere molto poco italiano” del secondo.
Per Bellocchio gli interpreti vanno “coinvolti e sedotti: più facile farlo con gli uomini coi quali parto dalla mia esperienza e suggerisco una serie di cose che possono sentire, più difficile con le donne, che sono diverse, ma rappresentano anche un’occasione di confronto più affascinante”. Tuttavia non importa il metodo, ciò che conta è che l’attore riesca a restituire nel modo giusto il sentimento che il regista gli chiede di esprimere. Formule magiche non esistono, l’importante, ammette l’autore, è che sul set è che funzionino i rapporti umani. Bellocchio ha scelto di fare cinema perché come arte collettiva lo obbligava a confrontarsi con gli altri e perché il ruolo del regista lo rende il destinatario di tutti gli sguardi e di tutte le domande, e “dare risposte è un esercizio mentale che per me è terapeutico, anche se non sempre sufficiente”.
Luca Giagnorio, Il Cinema Ritrovato News
Foto di Lorenzo Burlando.