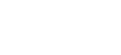Cinema libero 2018: uno sguardo all’Africa

Ancora una volta per merito di un attento e minuzioso lavoro di ricerca, la sezione Cinema libero del Festival Il Cinema Ritrovato ci permette di entrare in contatto con mondi e culture lontani e affascinanti. In particolare quest’anno l’attenzione dei selezionatori si è posta sulla cultura africana grazie a due lungometraggi del passato fortunatamente “ritrovati” e mostrati al pubblico del festival: Fad’jal e A Deusa Negra.
Nel caso di Fad’jal (Senegal 1979) siamo di fronte ad un’opera complessa e densa di spunti filosofici, politici e culturali. Si tratta di un documentario etnografico realizzato da Safi Faye, antropologa ed etnologa senegalese nonché prima cineasta donna subsahariana della storia. Il film affronta il tema della trasmissione della memoria storica e culturale della società africana attraverso la tradizione orale dal punto di vista di un piccolo villaggio senegalese di nome Fad’Jal. Come afferma in una scena del film colui che detiene la memoria storica della comunità, l’anziano del villaggio “in Africa un vecchio che muore è come una biblioteca che brucia”. La trasmissione del patrimonio culturale e storico africano è possibile solo attraverso una tradizione orale fatta di racconti, storie e canzoni. Al contrario, la cultura occidentale dei colonizzatori francesi è basata sulla scrittura e sulle biblioteche. Non è un caso che in una dalle prime scene del film vediamo i bambini seduti in classe a scuola che, quaderni alla mano, studiano la storia francese e in particolare Luigi XIV. L’intento è sottolineare il contrasto tra la storia scritta della Francia appresa a scuola e la storia africana tramandata oralmente di generazione in generazione.
Un altro tema sviluppato dal film è il rapporto tra la vita vissuta dagli abitanti del villaggio caratterizzata da un orgoglioso rispetto delle antiche tradizioni locali e una modernità sempre più incombente, minacciosa e aggressiva, incarnata dal centralismo statale del governo senegalese presentato come erede della tradizione coloniale francese. Nel corso del film si avverte con sempre maggiore intensità l’orgogliosa ostinazione di questa piccola comunità nel voler continuare a vivere secondo le proprie tradizioni e difendere il proprio territorio poiché come dice un personaggio del film “la terra appartiene chi la coltiva e non allo Stato”.
Un ruolo importante lo recita la colonna sonora caratterizzata da forti accenti ritmici. Numerose sono le scene di danza e di canto. La musica non è semplicemente una colonna sonora che arricchisce il film, ma una vera propria protagonista della pellicola che scandisce con la ritmica delle percussioni i più importanti momenti della vita del villaggio: dalla celebrazione di una nascita alla ritualizzazione della morte passando per il lavoro nei campi. Interessante infine notare che il film, pur presentandosi sotto una forma documentaristica caratterizzata da forti accenti di realismo e di fedeltà al mondo rurale (lo stesso da cui proviene la regista), è stato tuttavia studiato, preparato e scritto e non improvvisato.
Non meno ricco di spunti è A Deusa Negra (Black Goddess, Nigeria 1978) di Ọlá Balógun, pioniere del cinema africano, nonché primo regista nero a girare un film in Brasile. Anche in questo caso il tema della tradizione della memoria e dell’appartenenza alle proprie radici recita un ruolo importante. A Lagos, in Nigeria, un padre anziano e morente trasmette al figlio il suo ultimo desiderio, andare in Brasile dove i suoi avi furono deportati e venduti come schiavi per ricercare una statuina della dea Yemaya, simulacro delle proprie origini familiari, e completare così il ciclo spirituale della famiglia. Questa volta, dunque, l’attenzione si sposta sul tema della schiavitù e dei profondi legami tra continente africano e americano e in particolare tra Nigeria e Brasile. Interessante notare che un tema come lo schiavismo spesso raccontato da cineasti bianchi e che in occidente negli ultimi anni ha goduto di un certo successo cinematografico grazie film importanti come 12 anni schiavo o Django Unchained sia stato in questo caso raccontato in maniera semi autobiografica 40 anni fa da un regista africano come Balógun, che ha avuto degli schiavi deportati in Brasile tra i suoi antenati di parte materna. Il rapporto tra schiavismo e Brasile suscita tuttora interesse. Si tratta infatti di un tema storico non sufficientemente affrontato dalla cinematografia contemporanea. Troppo spesso si tende a concentrare l’attenzione sullo schiavismo negli Stati Uniti d’America e le conseguenti ripercussioni che questo ha avuto sulla società statunitense contemporanea. Ma lo schiavismo è stata una crudele pratica diffusa nell’intero continente americano e che in Brasile ha avuto grande successo e la cui eredità è arrivata fino ai nostri giorni. Le ferite dovute ai contrasti tra i padroni bianchi e gli schiavi neri non sono ancora del tutto rimarginate e nel più grande paese sudamericano i contrasti razziali pur attenuati rispetto al passato sono ancora profondi.
Un altro spunto importante del film è la religione yoruba nelle forme della magia, del misticismo e della reincarnazione. Dall’attenzione e dalla passione con cui il tema del culto è raccontato nel film si deduce una certa fascinazione una forte curiosità da parte del regista, pur agnostico, nei confronti del tema e una certa soddisfazione nel mostrare allo spettatore come riti così antichi possano sopravvivere, pur in una forma minoritaria e quasi “clandestina”, anche nella comunità nera brasiliana a lui contemporanea creando un legame indissolubile tra passato e presente, una sorta di ponte metafisico tra due continenti così lontani geograficamente ma così vicini culturalmente.
Francesco Pellegrini