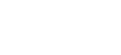Marco Ferreri ritrovato

Il cinema di Ferreri ha segnato più stagioni del cinema europeo, tra Spagna, Francia e Italia, e incontrarlo oggi ci fa misurare tutta la distanza tra i nostri anni e un’epoca in cui, all’interno del cinema ‘ufficiale’, erano consentiti azzardi tematici e narrativi oggi impensabili. Questa breve scelta di titoli, oltre a riproporre alcuni suoi classici come La grande bouffe, vuole illuminarne radici e aspetti meno noti. A cominciare dalle origini: il prologo come produttore all’interno del tardo neorealismo, in una fase di passaggio del cinema italiano (Donne e soldati, L’amore in città, il curioso cortometraggio di Alberto Moravia) e la fase spagnola di fine anni Cinquanta (con El cochecito). Nei primi anni Sessanta Ferreri è quasi mimetizzato nella commedia all’italiana e della sua unicità si accorgono, meglio dei critici, censori e produttori, che intervengono a bloccare, sabotare e mutilare pressoché tutti i suoi titoli (e di questa fase recuperiamo uno dei suoi capolavori, l’episodio Il professore). Ferreri vie- ne scoperto dopo il ’68 con film metaforici e apocalittici che furono interpretati in chiave politica ma che oggi ci sembrano mostrare soprattutto la fine dell’utopia.
Un segreto del regista è forse, in effetti, questa ambivalenza. Antonioni ha detto di lui: “È un grande regista ma ha un problema: ha paura delle donne”. Si potrebbe sostituire il ma con un perché. Ferreri è ossessionato, mortalmente attratto dalle donne, come dall’utopia, dai mondi possibili. E un rapporto simile ha anche con le figure infantili dei suoi film: portatori di domande, di inquietudini. Ma proprio questa ambiguità rende i suoi apologhi sconcertanti e non univoci.
L’altra cosa che emerge, a rivedere i suoi film nella lontananza dei decenni, è la straordinaria forza dei set. Ferreri, che ostentava uno stile trasandato, una lavorazione a volte improvvisata e quasi da commedia dell’arte, era però anche un grande pittore di luoghi, che utilizzava per costruire le sue performance filmiche: dalla Dubrovnik dell’Harem alla Capalbio post-atomica della Cagna, alle Halles in cui ambientare addirittura un western (e da una certa fase, infatti, risultava autore, oltre che della regia, dell’‘ambientazione’). Ancora una volta, un’ambiguità: lo scontro tra l’ineluttabilità degli apologhi e l’apertura ai luoghi. Come in uno dei più belli tra i suoi titoli tardi, Diario di un vizio, girato in un’estate romana speculare a quella di Caro diario di Moretti, a volte negli stessi luoghi: ma film di morte e di follia quanto quello era un viaggio di vita e di scoperta.
Emiliano Morreale
Programma
Martedì 25/08/2020
15:30
Cinema Odeon
Marco Ferreri ritrovato: DONNE, SOLDATI E…
Marco Ferreri ritrovato: DONNE, SOLDATI E…
Anna Malerba e Emiliano Morreale
Mercoledì 26/08/2020
15:30
Cinema Odeon
L’INFEDELTÀ CONIUGALE / IL PROFESSORE / MARCIA NUZIALE
L’INFEDELTÀ CONIUGALE / IL PROFESSORE / MARCIA NUZIALE
Emiliano Morreale
Giovedì 27/08/2020
15:30
Cinema Odeon
LA DONNA SCIMMIA
LA DONNA SCIMMIA
Gabriela Trujillo (Cinémathèque française)
Venerdì 28/08/2020
15:30
Cinema Odeon
EL COCHECITO
EL COCHECITO
Sabato 29/08/2020
15:30
Cinema Odeon
BREAK UP – L’UOMO DEI CINQUE PALLONI
BREAK UP – L’UOMO DEI CINQUE PALLONI
Domenica 30/08/2020
15:30
Cinema Odeon
LA GRANDE BOUFFE
LA GRANDE BOUFFE
Serge Toubiana
Lunedì 31/08/2020
15:30
Cinema Odeon
DIARIO DI UN VIZIO
DIARIO DI UN VIZIO
Serge Toubiana