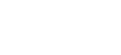“Memphis Belle” e “Le sang des bêtes”: gli effetti del cinema sulle barbarie umane.

Elaborare una narrazione personale significa essere presente, avere una coscienza, fare esercizio della propria individualità. In questo processo, gli spettatori non sono necessariamente il termine ultimo della comunicazione, ma si trasformano nello strumento attraverso cui il regista consacra la propria umanità. E così, ritagliare il proprio punto di vista, la propria prospettiva sulla bestialità umana, può essere visto come gesto formale per rendere la propria percezione un oggetto concreto, condivisibile.
Al contempo, la rappresentazione della violenza esce distorta dallo sguardo della camera, dall’esigenza della rappresentazione che inevitabilmente aggiunge o toglie qualcosa a ciò che mostra. E ciò avviene sempre, nonostante la pretesa realista del linguaggio documentaristico.
Lo stile del regista William Wyler, ad esempio, è caratterizzato dell’effetto di realtà: la suggestione ricercata dall’autore è quella di una presa diretta su quanto si vede, con inquadrature ampie e statiche, al cui interno è possibile scegliere il dettaglio su cui soffermarsi, regalando allo spettatore l’impressione di costruire la propria lettura della scena col solo orientamento dello sguardo.
Tutto ciò si sposò benissimo con l’esigenza documentaristica. La produzione di La bella di Memphis è avvenuta per la gran parte in condizioni a dir poco estreme: riprese effettuate in posizioni rischiose e faticose da mantenere, sugli aerei militari dell’epoca, non depressurizzati né riscaldati, con temperature che facilmente raggiungevano i -30°, con stralci di film montati sugli aerei stessi per economia di tempo. La realtà portata in scena è dura ed estrema, così come le prove cui si sottoposero i realizzatori dell’opera. L’asperità delle condizioni militari non è solo soggetto della rappresentazione, ma anche realtà in cui immergersi.
Forse per spirito d’avventura o per pura passione, Wyler si imbarcò in un bombardiere come volontario, entrando a far parte della missione militare come membro organico prima ancora che documentarista. Eppure, nel film di propaganda non c’è spazio per opinioni, considerazioni personali, report in prima persona, non c’è spazio per l’uomo: sullo schermo c’è una realtà presunta, e c’è il mezzo cinematografico, cioè la cornice traverso cui ci è dato guardare, in assenza di una mediazione palese. La voce narrante, coi toni tipici della propaganda di guerra, esprime una visione più che parziale, inevitabilmente schierata, cui però non si può che dare ragione. Una narrazione tanto perentoria da non lasciare spazio a contrapposizioni: l’unico spazio, esterno a questa visione, è quello del nemico. Con me o contro di me, non esistono stadi intermedi.
Con Il sangue della bestia, invece, Georges Franju si muove attorno a procedure ordinarie, nascoste ma non segrete, debitamente allontanate dal campo visivo della società.
Metafora dissacrante delle barbarie dei campi di concentramento, che solo pochi anni prima erano state mostrate dai cinegiornali, il corto mutua il linguaggio codificato del cinema documentaristico di matrice scientifica. Vi si mostra la gestualità e gli strumenti, la routinarietà della soppressione della vita, la banalità della cerimonia, espressa dai fotogrammi in cui uno degli addetti al macello si distacca dall’operazione di morte per bere da una tazza, guardando distrattamente fuori dall’inquadratura.
Qui la concretezza dei gesti è assoluta protagonista e si staglia su una scenografia ricercata, non creata o simulata ma attesa, prevista, calcolata. Calcoli accurati hanno stabilito le condizioni per ottenere l’immagine perfetta: perché i fumi del mattatoio riempissero l’inquadratura nel modo ideale, sarebbe servita la luce artificiale, quindi si aspettò novembre; perché i profili delle case sembrassero appiattiti, compatti con il cielo plumbeo, si aspettarono le nuvole dense di prima della pioggia. Il sangue che scorre copioso sulla scena è vivido, nonostante il bianco e nero. Si tinge dei colori delle forti sensazioni, della ripugnanza.
Tutto è costruito, tutto è finzione. Il documentario è una categoria del cinema e, in quanto tale, è creazione di simboli.
I movimenti dell’obiettivo sulla realtà, la sua danza tra gli spazi di luce e ombre, sono una delle poche occasioni che si offrono a un essere umano per rendere concreta l’esperienza, astrarla da sé, e quindi dalla fallibilità della propria percezione. A volte si riprende per mostrare qualcosa di inedito, come quando si decide di rischiare la vita per seguire l’ultima missione di un bombardiere della la Seconda Guerra Mondiale. Altre volte si mostra la macellazione di un cavallo, indugiando con la cinepresa sulla gestualità codificata della morte, sulla violenza messa a sistema.
In entrambi i casi, ad andare in scena non è il dolore, ma il raccapriccio per la capacità mortifera degli esseri umani. L’oggetto dei nostri film è, dunque, la paura che l’uomo prova per l’uomo stesso.
Approfondimento di Annalisa Prestianni
Nell’ambito del corso di Alta Formazione per redattore multimediale e crossmediale, nel progetto di formazione della Cineteca di Bologna.