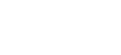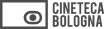LIEBE
Sc.: Paul Czinner dal romanzo di Honoré de Balzac Histoire des treize – La Duchesse de Langeais. F.: Arpad Wirgah e Adolf Schlasy. Scgf: Hermann Warm e Ferdinad Bellan. In.: Elisabeth Bergner, Leopold von Ledebur, Hans Rehmann, Agnes Esterahzy, Elza Temary, Olga Engl, Paul Otto, Karl Platen, Iaro Fürth. P.: Phoebus Film A.G. Berlin. M.: Willy Schmidt Gentner.
Lunghezza originale: 2.697m. Lunghezza della versione restaurata: 2.438. 35mm.
Scheda Film
La presentazione di Liebe (1928) in occasione de Il Cinema Ritrovato mi permetteva una piccola riflessione, artistica ed umana, su questa grande attrice di lingua tedesca. Nata in Galizia nel 1888 e morta nel 1986 a 98 anni a Londra, nell’elegante Eaton Square, potè godere anche in età avanzata della stima del suo pubblico, dopo che, grazie a riprese cinematografiche e televisive, era ritornata nella vecchia patria artistica. Come in gran parte dei suoi film, anche in Liebe suo marito, il regista tedesco-ungherese Paul Czinner, firma sceneggiatura e messa in scena. Ma, Herbert Jhering, che accanto a Alfred Kerr era allora il più importante critico teatrale e cinematografico di Berlino, ritenne di dovere concludere la recensione del film con questa frase: “Il sig. Paul Czinner è un fallito”.
Elisabeth Bergner veniva dalle sconfinate distese di quelli che una volta erano i territori austriaci della Polonia orientale, visse a Vienna e Zurigo e con la sua arte, che traeva origine dal feuilleton di Vienna (almeno secondo Jering), conquistò Berlino, la capitale teatrale degli anni Venti.
Osservando il suo volto segnato da grandi occhi stupiti, non è difficile scoprirvi un seducente smarrimento e un tenero, anche se presunto, bisogno di protezione. La sua recitazione così ricca di immedesimazione, ma anche così elaborata – le spalle raccolte, simili alle ali di un uccello spaventato – definita talora anche ‘arte nervosa’ (Kerr la definisce anche come “una forza che affonda”) provocò già all’epoca accese discussioni tra i critici e, tra il grande pubblico un frenetico entusiasmo oppure un freddo rifiuto. Tanto che si creò il caso Bergner, sia per la sua arte e i suoi cambiamenti di umore sia per i suoi compensi. Nonostante la stima di cui godeva e l’entusiasmo che suscitava, Herbert Jhering, in occasione della presentazione del Romeo e Giulietta per la regia di Reinhardt nell’ottobre 1928 a Berlino, dichiarò: “Il caso Bergner è l’ultima manifestazione inflazionistica del teatro tedesco”, dopo che già in precedenza aveva avvertito di non farne la “Duse tedesca”.
“Ogni critico, se non è un poeta, inciampa inevitabilmente nella coda della cometa di Elisabeth”, ha detto della Bergner Else Lasker-Schüler. Sia perché le stelle fulgide accecano, sia perché le punte di queste stelle sono spesso molto acuminate.
A Berlino, sotto la regia di Max Rheinhardt divenne una delle più celebrate attrici teatrali degli anni Venti. Anche il cinema puntò i suoi riflettori su di lei. Non fu comunque colui che divenne suo marito, Paul Czinner, a farla esordire sullo schermo, come lei ha sempre sostenuto – e successivamente a dirigere tutti i suoi film fino a Stolen life girato in Inghilterra nel 1939 – bensì Holger-Madsen nel 1923 con Der Evangelimann tratto dall’omonima opera di Wilhelm Keinzl, nel quale la Bergner esordì nel ruolo della figlia gobba di un sarto.
Se dobbiamo credere ai racconti dei suoi colleghi, già allora, senza che questo termine esistesse, la Bergner aveva sviluppato un ruolo manageriale e autonomo di public-relation che, indipendentemente degli organi allora deputati a questa funzione quali la stampa e la radio, prevedeva come interlocutori persino le venditrici dei mercati rionali e le commesse dei negozi che frequentava.
A seconda dei vantaggi che poteva offrire di volta in volta la situazione, con molta astuzia allacciava o rifiutava amicizie, traendo naturalmente giovamento all’inizio della sua carriera della sua apparizione come elfo oppure come donna-bambina col vestitino a sacco o in calzoncini. Comunque è sempre stata sua intenzione “mettersi in vista”, anche a discapito a volte della sua immagine.
Nel maggio 1922, in Des Esels Schatten di Ludwig Fulda, uno spettacolo teatrale ora raramente rappresentato, fu per la prima volta partner di Heinrich George. L’impressione che esercitò sull’attore fu enorme. Nella tenera adorazione scaturita da questo incontro lui, che per un motivo futile era capace di cacciare fuori dall’auto una collega nel bel mezzo di un raccordo, era disposto a tollerare i capricci della Bergner e persino scherzi non degni di una collega. E chiudeva un occhio persino quando – sia che si trattasse della Fraulein Julie di Strindberg, che del Richard II di Shakespare – durante le prove la Bergner pareva non riuscire a venire a capo di un ruolo, per poi arrivare a surclassare George durante la prima. Sebbene la capisse, nonostante il suo affetto suscitava in lui una sempre maggiore irritazione. Se lui l’apostrofava, nel suo stile taurino, come i più nel suo ambiente, con “sgualdrina”, lui veniva apostrofato da lei, ma anche dalla sua famiglia e dai suoi amici più intimi, con l’appellativo di “coglione”.
I pochi testimoni e ammiratori, ancora viventi, della sua arte – che allora non incontrò assolutamente un apprezzamento unanime nè dalla critica, nè dal pubblico – con la quale Elisabeth Bergner in modo intelligente e con istinto sicuro penetrava nelle zone di una femminilità sensuale, con l’impronta della donna bambina, sarebbero ancora oggi disposti, nonostante la sua età avanzata, a ingaggiare un duello, quantomeno verbale, con gli scettici, che nella sua arte recitativa hanno ravvisato unicamente trucchi e montature. Per potere ora esprimere entusiasmo o rifiuto rispetto alla sua presenza sulla scena, noi ci basiamo unicamente sulle recensioni favorevoli o sfavorevoli di critici come Alfred Kerr oppure Herbert Jhering; ma solo i suoi film ci consentono di formulare un giudizio diretto. Sono infatti proprio i film che rendono evidente come la sensibilità intellettuale della grande attrice abbia permesso la costruzione di straordinarie figure femminili come Nju (Nju, 1924), Renée (Der Geiger von Florenz, 1926), Juana (Doña Juana, 1928), Else (Fraulein Else, 1929) oppure Ariane (Ariane, 1931 – suo primo film sonoro); così come indelebili nel nostro ricordo restano le sue interpretazioni più tarde, che ci ha regalato tornata dall’emigrazione forzata, in teatro, sui set cinematografici e televisivi: Die Glucklichen jahre der Thorwalds (1962), Nachtdienst (1975), Der Pfingstauslug (1979), Der Garten (1982) e Geliebter Lugner (1963). In tutte queste opere riconosciamo senza alcun limite la sua grandezza recitativa sia nella rappresentazione di caratteri che nell’interpretazione di testi poetici. Con la saggezza della vecchiaia e con grande consapevolezza ha abbattuto i muri del proprio mito, che sia il pubblico che la critica avevano contribuito a costruire, ed è diventata il personaggio a tutto tondo, che è sopravvissuto nel nostro ricordo. (Eberhard Spiess)