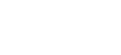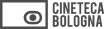TRISTANO E ISOTTA
S.: da un poema della “Tavola Rotonda”. In.: Francesca Bertini (Isotta), Giovanni Pezzinga (Tristano), Bianca Lorenzoni (la schiava), Serafino Mastracchio (Re Marke). P.:Film d’Arte Italiana. L.O. :620m. D.:28’. 35mm.
Scheda Film
Ben poco fino ad oggi si è potuto vedere della produzione della Film d’Arte Italiana, attiva dal 1909 al 1920 con oltre 160 film, spesso liquidata dalle storie del cinema come una modesta emulatrice della Film d’Art francese. Tristano e Isotta, assieme alle altre opere FAI presenti in rassegna – Lucrezia Borgia (1912), Una congiura contro Murat (1912) e, per altre ragioni, Fiamma Simbolica (1919) -, permetterà di valutare meglio le qualità di questa Casa: accuratezza della messinscena, estrema professionalità delle interpretazioni, fascino figurativo e pittorico, straordinaria qualità delle colorazioni “au pochoirs”.
Citiamo di seguito alcuni brani di un accuratissimo saggio (contenuto in R.Redi (a cura di), Pathé, Roma, Di Giacomo Editore, 1989) che Aldo Bernardini ha dedicato alla FAI e che ha consentito di chiarirne storia ed evoluzione:
“Dopo la costituzione ufficiale della società, Lo Savio si occupò di reclutare i quadri tecnici e artistici di cui aveva bisogno. Applicando i criteri già seguiti dalla Film d’Art in Francia, si rivolse prima di tutto agli ambienti del teatro romano e riuscì a coinvolgere, tra i primi, Ugo Falena, commediografo, critico e regista teatrale di buon nome, già direttore della compagnia del Teatro Argentina.
Falena in un primo tempo fece l’assistente di Lo Savio, che aveva assunto la direzione artistica della FAI, fornendo anche soggetti e prestandosi come attore, prima di diventare lui stesso realizzatore. […] Almeno nei primi tempi, Lo Savio e Falena poterono comunque contare sull’apporto e sull’assistenza di specialisti francesi, provenienti dalla Pathé più che dalla Film d’Art: fino ad oggi risultano precise testimonianze solo sulla presenza a Roma per alcuni mesi di Louis Gasnier, il regista dei primi film di Max Linder, attivo presso la Pathé fin dal 1905 e divenuto negli anni Dieci una specie di esperto e consulente per le attività all’estero della Casa Madre; ma è molto probabile che anche altri registi e tecnici francesi fossero venuti allora ad insegnare i segreti del mestiere ai giovani cineasti della FAI. […] Lo Savio e Falena reclutarono poi i primi attori protagonisti della FAI nelle compagnie che erano allora attive a Roma, soprattutto in quelle che facevano capo al Teatro Argentina: entrarono così nei primi film prodotti dalla nuova Casa Dante Capelli, Cesare Dondini, Alberto Nepoti, Ferruccio Garavaglia e, come prima donna, Vittorina Lepanto: tutti con alle spalle una discreta esperienza di palcoscenico.
E, sempre a imitazione di quanto già faceva la Film d’Art francese, Lo Savio si preoccupò, tra i primi in Italia, di segnalare fin dal 1909, nella pubblicità e nei manifesti, i nomi degli interpreti dei film prodotti dalla FAI (aggiungendo a volte anche quello degli “autori” dei soggetti), anticipando così una consuetudine che si sarebbe diffusa nel cinema italiano soltanto qualche anno dopo, con l’avvento del film a lungometraggio. La politica di apertura della FAI verso i teatranti diede i suoi frutti migliori soprattutto negli anni 1910 e 1911, e culminò nel coinvolgimento di uno dei nomi più prestigiosi della scena nazionale, Ermete Novelli, ingaggiato con tutta la sua compagnia per La morte civile e per due riduzioni shakespeariane. Ma all’epoca non mancarono di impressionare il pubblico e gli addetti ai lavori anche le partecipazioni a film della FAI di altri attori abbastanza noti, come Achille Vitti o Dillo Lombardi. […]
Lo Savio e Falena […] dimostrarono di avere un ottimo fiuto per scoprire le possibilità cinematografiche di volti nuovi, di attori improvvisati. La FAI diventò così in quei primi anni un vivaio di giovani carriere nel cinema italiano; e, oltre al caso più clamoroso della già più volte citata Francesca Bertini, occorre ricordare quelli di Gabriellino D’Annunzio, di Maria Jacobini, dì Gastone Monaldi e di Carlo Duse, tutti esordienti in film FAI nel 1910, e, negli anni successivi, quelli di Fernanda Battiferri, di Gustavo Serena, di Alfredo Robert, di Lamberto Picasso. Senza dimenticare i futuri registi – il già citato Lucio D’Ambra, ma anche Augusto Genina, esordiente alla FAI come soggettista nel 1912 – e gli scenografi e “allestitori” Duilio Cambellotti e Rodolfo Kanzler, ingaggiati mentre stavano lavorando all’Argentina.
A buon diritto quindi nel 1912 la Pathé rivendicava l’importante caratteristica funzione svolta dalla FAI nel cinema italiano, il merito cioè di avere “vinto per la prima la ritrosia dei più celebri ed intelligenti artisti italiani a posare per il cinematografo”, oltre che di “avere addestrato alla scena cinematografica gli artisti più modesti che sono venuti a lei e che sono riusciti a costruire una vera e propria maestranza dell’arte cinematografica”. In un altro, anonimo intervento sulla rivista specializzata “Il Cinema-Teatro”, probabilmente sponsorizzata dalla FAI, un altro critico segnalava tra i nomi nuovi della FAI “Fanny Liona dal sorriso incantatore” e, quando ancora nessuno la conosceva, la bella Francesca Bertini: “gli atteggiamenti scultorei e l’angelica dolcezza della fisionomia la fanno quasi confondere con un modello di Tiziano”.