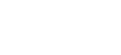Szegénylegények
T. it.: I disperati di Sandor. T. int.: The Round-Up. Scen.: Gyula Hernádi. F.: Tamás Somló. M.: Zoltán Farkas. Scgf.: Tamás Banovich. Su.: Zoltán Toldy. Int.: János Görbe (János Gajdar), Zoltán Latinovits (Imre Veszelka), Tibor Molnár (Kabai), Gábor Agárdy (Torma), András Kozák (Kabai figlio), Béla Barsi (Foglár), József Madaras (Magyardolmányos), János Koltai (Béla Varjú). Prod.: MAFILM IV. Játékfilmstúdió. Pri. pro.: 6 gennaio 1966. 35mm. D.: 87′. Bn.
Scheda Film
Anni intorno al 1860: il governo austro-ungarico si appresta a sterminare quel che resta dei ribelli di Kossuth, i combattenti della libertà, gli uomini di Sandor. È il punto di partenza di un gioco crudele tra gatto e topo, una lezione sulla soppressione dell’identità (e il finale del film una delle più agghiaccianti rappresentazioni della Storia che si compie). Allo spettatote non vengono forniti facili soggetti d’identificazione; la psicologia è spazzata via (pure essendo allo stesso tempo spietatamente presente) – tutto si concentra sul sistema e sulla storia, sulla burocrazia e sull’opportunismo, sulle utopie che non hanno avuto futuro.
Passato o presente. È questo il cuore del cinema ungherese degli anni Sessanta. Gli eventi di I disperati di Sandor hanno luogo nel decennio che si apre con il 1860, ma, nelle parole di Jancsó, “tutti sapevano che si stava parlando degli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento” – semplicemente, per rispondere a un’interrogazione proveniente da Mosca o da Berlino Est era più facile obiettare che si trattava “di una film storico, non riferito ai nostri tempi”…
La corrispondenza tra passato e presente, d’altra parte, poggia su solide basi: prima di tutte la puszta che si estende immensa, fuori dal tempo, fino all’eternità. I disperati di Sandor fu la prima manifestazione di un ‘metodo’ destinato a diventare leggenda del cinema moderno. Ancora nelle parole di Jancsó: “Girare scene di dodici minuti con una cinepresa a 35mm significava mettere insieme una complessa struttura di binari; si cominciava la scena la mattina presto e si finiva che faceva buio”. Un lavoro da virtuosi: “Il nostro metodo implicava un certo grado di follia, e la sua riuscita dipendeva dal fatto che tutti, attori e tecnici, fossimo amici – diversamente non sarebbe stato possibile” (un bel paradosso, dunque: camaraderie dietro le macchine da presa, e davanti la Storia, homo homini lupus).
Il metodo significava un rinnovamento del montaggio, trasferito all’interno del pianosequenza – quello che Marcel Martin ha definito ‘montaggio virtuale’. In questo magnifico Scope in bianco e nero, è la storia nuda e brutale che abbiamo davanti, e l’uomo intrappolato nella Storia. Scrive Michel Estève “Spezzando il corso della narrazione lineare, contraendo la durata, le ellissi restituiscono il clima d’angoscia soffocante della prigione. I contrasti fotografici dei neri e dei bianchi, molto duri, molto freddi, sia nel décor sia nei costumi, sottolineano la crudeltà dei boia. Nessuna partitura musicale, ma una colonna sonora di evidente realismo: il vento, la pioggia, gli zoccoli dei cavalli, le catene dei prigionieri. Tutto è uno spazio-prigione che si chiude intorno ai prigionieri. Lo spazio esterno sembra dilatarsi, aprirsi nei piani d’insieme e nella profondità di campo della puszta ungherese: ma non offre in realtà che un sogno, un’illusione di libertà: lo spazio (la pianura) si spalanca solo sulla morte”.
Se chiediamo al cinema di dispiegare davanti ai nostri occhi visioni della Storia, i kolossal storici alla Quo Vadis? sono la risposta ‘leggera’, mentre I disperati di Sandor rappresenta probabilmentre la risposta più profonda e coinvolgente alla nostra domanda: un momento alto nell’arte di Miklós Jancsó e nel cinema moderno, dove forma, metodo e oggetto diventano una cosa sola.
Peter von Bagh