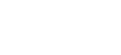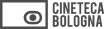LA FEMME ET LE PANTIN
R.: Jacques de Baroncelli. S.: dal romanzo di Pierre Louys. Scgf.: Robert Gys. In.: Conchita Montenegro (Concha Perez), Andrèe Canti, Raymond Destac (Don Matteo), Jean Dalbe (Morenito), Henri Levêque (André Stevenol). P.: Société des Cinéromans/Films de France.
L.: 2250m, D.: 100’, bn, 35mm
Scheda Film
La storia del film
“Il romanzo che Pierre Louys diede alle stampe nel 1898, La femme et le pantin, ebbe un successo forse spropositato ai suoi meriti e venne letto con avidità dai lettori che, a cavallo dei due secoli, cercavano delle emozioni forti. Poteva il cinema disinteressarsi di un titolo che, a torto o a ragione, spingeva gli editori a sempre nuove ristampe? L’ultima era avvenuta nel 1927, poco dopo la morte dello scrittore. L’anno seguente, sulla traccia del romanzo e della pièce che Pierre Frondaie ne aveva ricavato per una versione teatrale, Jacques de Baroncelli ne trasse la prima versione cinematografica, utilizzando peraltro un sistema di colorazione di alcune sequenze, il ‘Keller-Dorian’, di cui è rimasta scarsa traccia nelle storie della tecnica cinematografica.
La femme et le pantin arrivò sugli schermi parigini alla fine di maggio del 1929 (in Italia uscì qualche mese dopo come Conchita), al pubblico piacque, ma la critica avanzò qualche riserva. René Olivet su Cinémonde rimproverò a Baroncelli un certo rigore nei confronti di un testo debordante di sensualità, una mancanza di coraggio nel realizzare in immagini le crisi voluttuose e la prurigine del desiderio che sono l’orditura del romanzo di Louys.
Lodi incondizionate invece per Conchita Montenegro, un’attrice d’origine spagnola piena di felina seduzione, accanto alla quale quei carneadi scelti come partners appaiono dei veri e propri pantins.
Il film scomparve dagli schermi molto presto, scalzato dai film sonori ed è opera completamene sconosciuta alle attuali generazioni: non così le successive versioni del fortunato romanzo, per molti versi suggestive di Sternberg con la Dietrich, di Duvivier con la Bardot e di Buñuel, la cui ‘femme’, oscuro oggetto del desiderio, si sdoppia nei volti delle enigmatica Carole Bouquet e dell’acre Angela Molina”. (Vittorio Martinelli)
Il film
“Come conduce Conchita il suo flamenco di seduzione? Nel più vecchio, nel più vieto dei modi: attraverso la fuga e il ritorno inatteso, la sottrazione, la dilazione del desiderio. A strategia tanto anonima, a tanta ovvietà romanzesca, si cerca di far corrispondere l’eccezionalità di momenti che appaiono come piccoli smottamenti, o come catastrofi visive. C’è sempre qualcosa che si frappone tra lo sguardo di Don Mateo e il suo oggetto; prima, il vetro divisorio all’interno del treno; quindi, nel primo incontro a casa di Conchita, una porta chiusa dalla quale emerge e si allunga un braccio candido, una tenda oltre cui si intravvede il profilo di un corpo nudo. ‘Voglio stare qui, riposarmi un poco…’: Baroncelli non manca di recuperare anche il dato erotico della stuoia fresca, per i privati languori di un corpo intoccabile. Più tardi, sarà il ferro battuto di grate impenetrabili e di un cancello chiuso a segnare la definitiva sconfitta, la fin troppo metaforica esclusione di Don Mateo (anche questo lo ritroveremo in Buñuel). Dentro questa strategia, il corpo nudo non è un’occorrenza marginale o sfumata: Conchita sarà insolentemente e “artisticamente” nuda nella scena più complicata, più costruita e più sorprendente del film, il flamenco proibito ad uso del pubblico inglés: dove il composto e letterario Baroncelli, per restituire una visione davvero catastrofica, arriva persino ad interrompere i codici del linguaggio ordinario per sfiorare quelli di una (non più nuova) avanguardia”. (Paola Cristalli)
La musica
“Georges van Parys è uno dei musicisti più prolifici e longevi del cinema francese, capace si superare indenne il passaggio dal muto al sonoro agli inizi degli anni Trenta. Dotato di una grande facilità inventiva e di una vena generosa congiunte a una solida tecnica, ha saputo caratterizzare i film da lui musicati con l’impronta forse demodée ma del tutto particolare legata alla tradizione della chanson parigina.
La sua carriera di compositore inizia infatti come autore di canzoni per il teatro leggero; il mondo del vaudeville e dell’operetta francese sono alla base della sua musicalità facile e popolare ma non priva di ironia e di nostalgia. Il mondo perduto della belle époque è ovunque presente nei suoi lavori, e questo amore per la vecchia Parigi ne ha fatto l’interprete ideale per i film di René Clair, col quale vanta infatti un rapporto di lunga e feconda collaborazione.
Per La femme et le pantin (tratto dal romanzo di Pierre Louys che ispirò anche Buñuel per il suo Quell’oscuro oggetto del desiderio) Van Parys, affiancato qui come in altre numerose occasioni da Philippe Parès, ha attinto a piene mani alla musica popolare spagnola, costruendo la sua partitura attorno a ritmi di habanera e di fandango, danze zigane e modi folkloristici di chiara derivazione araba.
Le numerose scene di danza all’interno del film rivivono di un umore popolaresco che, al di fuori della Spagna, solo un musicista a contatto con la Parigi di quegli anni poteva infondere alla propria musica.
L’influenza della musica spagnola su quella francese dei primi decenni del secolo è infatti assai visibile, segnatamente nelle opere di Debussy e Ravel, grazie soprattutto all’influenza esercitata da Albeniz negli anni del suo trionfale soggiorno parigino. La carica sensuale e l’indecifrabile passione di Conchita come lo struggimento amoroso di Don Mateo sono così resi in modo magistrale da una scrittura musicale brillante e agilissima, dai profumi intensi e inconfondibili.
La versione qui presentata è una riduzione per quattro strumenti dell’originale stesura per piccola orchestra da camera”. (Marco Dalpane)