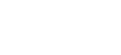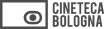LA BELLE NIVERNAISE
R.e Sc.: Jean Epstein. S.: dalla novella di Alphonse Daudet. F.: Paul Guichard, Léon Donnot. M.: Jean Epstein, René Alinat. In.: Blanche Montel (Clara Louveau), Mme Lacroix (La mère Louveau), Maurice Touzé (Victor Maugendre), Pierre Hot (le père Louveau), Jean-David Evremond (Maugendre), Roger Chantal, Pierre Ramelot, Georges Charlia, Max Bonnet. P.: Pathé.
D.: 90’, 35mm.
Scheda Film
Nel 1924 Jean Epstein aveva ventisette anni e, nonostante la giovane età, era considerato da molti un maestro del cinema francese. L’anno precedente il suo Coeur fidèle, con la celebre sequenza della fête foraine, aveva riscosso i consensi pressoché unanimi della critica, soprattutto quella più legata alle esperienze dell’avanguardia. Coeur fidèle era stato, per gli intellettuali e gli appassionati parigini, il film da vedere, un vero e proprio avvenimento. Dopo quel successo, Pathé aveva mandato Epstein in Sicilia a riprendere l’eruzione dell’Etna: da questa importante esperienza dovevano derivare un breve documentario, La Montaigne infidèle – purtroppo perduto – e un volumetto di scritti sul cinema, il magistrale Le Cinématographe vu de l’Etna. Nel libro, uscito nel 1926, Epstein raccoglieva alcuni dei suoi testi più importanti degli anni precedenti, situandoli nel contesto del viaggio in Sicilia. Sorprendentemente, in un momento in cui ferveva il dibattito sul cinema puro e sui destini dell’avanguardia, Epstein prendeva in molti passi del testo le distanze dagli stilemi, delle procedure e anche degli intenti dell’impressionismo cinematografico, affermando ad esempio che il montaggio accelerato, una volta considerato una scoperta, era diventato una moda finanche un po’ ridicola. Ancora più netta era la condanna delle esperienze astrattiste e di “cinema assoluto”, paragonate al “caleidoscopio, giocattolo della seconda infanzia”.
A questa esigenza di salvaguardare la novità del cinema, le sue specificità profonde – anche contro troppo facili incasellamenti in scuole, tendenze, poetiche -, ben corrisponde, sul piano realizzativo, un film come La Belle Nivernaise, apparentemente assai distante dallo sperimentalismo di Coeur fidèle e che da alcuni è stato considerato come il frutto delle necessità alimentari del giovane Epstein. La necessità era invece quella di liberarsi delle incrostazioni di una maniera, di non fare di Coeur fidèle un modello da replicare all’infinito, e di attingere invece ad una sorta di classicità, di semplicità e immediatezza del racconto. Il film, tratto da un romanzo di Alphonse Daudet, racconta la storia di un ragazzo adottato dai proprietari di una chiatta, la Belle Nivernaise, che vive felice sul fiume in compagnia di una ragazza con cui condivide giochi e lavoro, fino a quando il padre naturale non lo porta via con sé Il ragazzo, lontano dai luoghi e dalle persone amate, si ammala e sta per morire. Al padre non resta che renderlo a chi ha saputo dargli la felicità. Ci si troverebbe dunque nell’ambito di un genere, il melodramma rurale, piuttosto praticato all’epoca; tuttavia per Epstein l’intreccio è secondario rispetto alla possibilità di far risaltare la poesia dell’ambientazione: il fiume, l’acqua, le chiuse e il paesaggio attraversato dalla chiatta nel tragitto da Parigi a Rouen. E’ dunque la Senna, scoperta attraverso campi lunghi e movimenti di macchina, ad essere protagonista, a raddoppiare le sensazioni e i sentimenti dei personaggi.
Se in più momenti La Belle Nivernaise fa già pensare a Vigo, per la lenta fluidità delle immagini paesaggistiche esso va piuttosto avvicinato ai migliori risultati del cinema nordico. Nelle parole di Langlois: “Come tutti i giovani, Epstein sentiva il bisogno, dopo aver assimilato le scoperte del cinema francese, di assicurarsi la fluidità di uno Stiller, di un Griffith, di tutti quelli che a Hollywood o in Svezia cercavano di arrivare alle sorgenti profonde della semplicità. Questo fu La Belle Nivernaise, una delle opere più pure, più classiche, più squisite del cinema muto francese. […] Con il suo ritmo impercettibile all’intelletto, la sua perfetta semplicità, la sua sapiente spogliezza, la sua volontà di subordinare ogni cosa al soggetto, è certamente il film che la Francia può meglio opporre ai capolavori della scuola svedese” (Guglielmo Pescatore)