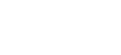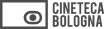IL CLARINO DI TONTOLINI
Int.: Ferdinand Guillaume (Tontolini), Matilde Guillaume (la fidanzata); Prod.: Cines 35mm. L.: 110 m. D.: 5’ a 18 f/s. Bn
Scheda Film
I resoconti storici del rapporto tra il cinema muto e l’antichità partono spesso dai primi lungometraggi di grande successo: Quo vadis? di Enrico Guazzoni del 1913 e Cabiria di Giovanni Pastrone del 1914. Ma l’interesse per l’antico Mediterraneo era stato uno dei tratti principali del cinema fin dal 1896, quando i fratelli Lumière portarono per la prima volta Nerone sullo schermo mostrandolo intento a sperimentare veleni sugli schiavi (Néron essayant des poisons sur des esclaves). Prima di Quo vadis? furono realizzate centinaia di film legati all’antichità e oggi ampiamente dimenticati, ignorati o dati per scontati ma che, nel loro insieme, costituiscono un enorme campo di ricerca che attende di essere studiato in maniera completa e approfondita. Se film come Quo vadis? ci invitano a guardare avanti, all’influenza dell’antichità classica sulla storia e sulla storiografia del cinema, un’altra importante domanda che attende risposta è da dove questi film vengano (come dire: Quo venis?). I cortometraggi e i mediometraggi ambientati nell’antichità e realizzati prima del 1913 spaziano dall’epica storica e mitologica agli adattamenti di drammi classici, ai burlesque, ai cartoni animati e ai documentari. Prodotti e distribuiti in molti Paesi europei e nel Nord America, dimostrano un interesse per il mondo antico che compete per intensità e ampiezza con quello che caratterizzò il periodo classico di Hollywood dagli anni Trenta agli anni Sessanta. Cosa rende il Mediterraneo un soggetto così interessante per il cinema muto? Il cinema delle origini cercava la legittimazione culturale civettando con lo status canonico di cui il mondo antico godeva nelle altre arti: la pittura, la scultura, la danza, il teatro e l’opera. Ugualmente importante, tuttavia, è il fatto che il cinema delle origini, nel suo cercare legittimazione culturale, ridefinì la visione dell’antichità classica. Esso riportò in vita ciò che si credeva morto, rimise in moto ciò che si credeva immobile e presentò in tutta la sua gloria ciò che si credeva decaduto e in rovina. Il cinema delle origini cercò nell’antichità classica modelli etici, politici o sessuali da emulare o antitipi con cui confrontarsi. In questo modo riaffermò visioni che incoraggiavano la fuga in un passato remoto ed esotico. Ma presentò anche l’antichità come un mondo in cui potevano essere messi in scena problemi moderni, spesso nei termini più stravaganti. Agrippina mostra il debito del genere con il teatro. I titoli di testa sono ornati da maschere tragiche e comiche. Gli attori sono presentati uno alla volta (comprese le celebrate dive Gianna TerribiliGonzales e Maria Gasparini). La trama riprende le macchinazioni dell’imperatrice romana dal punto in cui l’opera di Händel si era fermata. Diretto da Enrico Guazzoni per la Cines, Agrippina si ispira alle origini francesi dei film ambientati nell’antichità quando rimette brevemente in scena gli avvelenamenti sperimentali di Nerone, ma prefigura anche la pietra miliare del regista, Quo Vadis?, sia nel soggetto che nella sua elaborazione, attraverso la narrazione, i costumi, le scenografie e la coreografia delle scene di massa. Film come L’Orgie romaine / Roman Orgy di Feuillade si abbandonano a fantasie sull’antichità classica che distruggono il mondo degli spettatori per ricomporlo come spettacolo di un potere assoluto a un tempo esotico e trasgressivo: un imperatore effeminato, un Senato di donne, opulenza orientale e atti di violenza gratuita come i leoni che seminano il panico tra gli ospiti di un banchetto. I film ambientati nell’antichità non si limitavano all’Impero Romano. La regina di Ninive offre un assaggio dei molti altri luoghi e tempi dell’antichità. Il libro di Giona ha descritto Ninive (la capitale dell’antico impero assiro) come una città malvagia destinata alla distruzione. Quale miglior luogo per mettere in scena le inquietudini moderne sui rapporti coniugali, l’autorità dei padri, la vulnerabilità dei maschi e l’atteggiamento di sfida delle donne? La semplicità e l’innocenza pastorale delle scene girate in esterni si contrappongono all’adulterio e all’esotismo della corte e agli oscuri misteri dei suoi rituali nel tempio. Alla fine, delusa dalla vigliaccheria del suo amante, la regina si strappa la collana di perle e il diadema per indossare l’elmo e la corazza. È la sola a essere abbastanza virile da battersi contro il vendicatore di suo marito. I film di questo programma permettono di scorgere la rappresentazione dei diversi aspetti dell’antichità nel 1911. Il programma è la prima parte di una serie triennale che intende evidenziare alcuni sviluppi artistici, stilistici, tematici, tecnologici e di genere nelle pellicole legate al mondo antico che resero possibile la nascita dei kolossal epici della metà degli anni Dieci. Esso si concentra inoltre sul favoloso potenziale del cinema delle origini che sarebbe stato sviluppato solo in maniera selettiva dal cinema narrativo, e sul valore delle “tante strade non prese” dalle concettualizzazioni contemporanee dell’antichità. Gli altri film inclusi in questo programma offrono un piccolo assaggio della modernità del 1911, nel cui contesto possono essere meglio compresi i film sull’antichità. Queste notazioni nascono dal progetto di ricerca da noi avviato, The Ancient World in Silent Cinema. Il progetto è stato inaugurato con la proiezione a Londra, Los Angeles e Berlino di alcuni tra i più rari film sull’antichità (risalendo fino al 1903) ed è proseguito con lo studio di copie preservate negli archivi europei e statunitensi. Nel 2012 verrà pubblicata una prima raccolta di saggi, e i progetti successivi comprendono la creazione di una rete di studiosi e di archivi cinematografici, l’allestimento di una banca dati per la documentazione dei film, il restauro e la digitalizzazione di alcune pellicole e ulteriori proiezioni accompagnate da nuove partiture.
Pantelis Michelakis, Maria Wyke