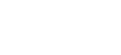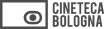DIE FUNF VERFLUCHTEN GENTLEMENT (versione tedesca de LES CINQ GENTLEMEN MAUDITS)
Se.: dal romanzo di André Reuze. F.: Armand Thirard, René Moreau. Scgf.: Lazare Meerson. M.: Jacques lbert. In.: Adolf Wohlbruck, Camilla Horn, Jack Trevor, Allan Durant, Georges Péclet, Marc Dantzer. P.: Société Générale de Cinématographie. D.: 75’. 35mm.
Scheda Film
Non abbiamo mai visto la versione francese di questo film “minore” di Duvivier. Eppure, a giudicare da quella tedesca, è un film ricco di interesse, certo irregolare e forse incompiuto, ma che conferma la grande stagione creativa che Duvivier stava attraversando in quegli anni.
Una storia banale fa da sfondo ad una costruzione dell’immagine che trasforma la realtà in movimenti. Lo spaesamento dei cinque giovani tedeschi incapaci di comprendere le ragioni della cultura araba è reso tangibile da uno spazio che si fa sfuggente e nemico e sottolineato da una colona musicale ricchissima, composta da suoni, rumori e frammenti di realtà, che si insertano di continuo nella finzione. A livello visivo il film resta spesso in bilico tra l’arditezza della ricostruzione e il documentario costruito con frammenti di realtà rubata. Una sola delusione: il viaggio si concluderà con la più banale delle scoperte, il nemico stava dentro al gruppo dei cinque amici.
Il regista, con la sua abilità, cerca di creare un po’ di interesse intorno ai personaggi (quasi marionette) e un po’ di movimento, grazie agli artifici della tecnica, intorno a un vuoto assai inquietante. “Il regista – scriveva un critico dell’epoca – ha voluto animare queste immagini facendo danzare la macchina da presa in modo folle, in tutti i sensi”. E aggiungeva: “Egli dimostra una grande abilità nell’immaginare simili giochi tecnici. Ma, dopo tutto, che senso hanno?”. A dire il vero Duvivier, man mano che il racconto procede, si disinteressa della vicenda e si dedica a riprendere i paesaggi marocchini in maniera piacevole. Il risultato sono due film che si ricorrono senza mai arrivare ad una sintesi efficace e dove il documentarismo finisce col prevalere e con l’assorbire la vicenda-pretesto. (R. Chirat, Julien Duvivier)
“Ciò che fa di questo film un grande successo, ciò che richiama tanto pubblico all’Olympia anche senza grandi spese in pubblicità, è la bella resa dell’esotica atmosfera del Marocco, con abbondanza di esterni del Nord Africa girati con tecnica esperta e spesso accompagnati da una colonna sonora molto appropriata. Il film beneficia della moda del travelog, con una storia di genere misterioso che fa da sfondo”. (Variety, 15/3/1932.)
“Accolto commercialmente con sfavore, questo film è il primo segno di un’arte originale e incidente. […] Lo stile del regista, applicato su breve scala, è già netto, conseguente e deciso. Non v’è incertezza alcuna nello svolgimento: solo notiamo una certa indulgenza al folklore, onde il regista è attratto. […] L’ambiente è magna pars dei film di Duvivier. Non è la vicenda per se stessa che ci rende attenti, ma il fatto ch’essa si svolga in Marocco. E se abbiamo accordata la dovuta importanza alla storia di Pepé le Moko, riuscirà, credo, interessante, vedere – per così dire – i preparativi di quel mondo a cui il regista si rileverà molto attaccato. La prima immagine del film – quell’effetto d’ombra, sull’acqua del mare, della nave che corre – testimonia lo studio dei grandi modelli (perché ci viene in mente il nome di Dreyer?); come quella specie di partita a tennis, prima della formidabile rincorsa finale, ci attesta che a virtuosità fotografiche (però anch’esse in funzione di qualche cosa: nell’ambiente siamo introdotti, nelle sue opere, come meglio non sarebbe possibile) questo nostro regista spesso s’abbandona. L’originalità si comincia a vedere quando quella nave giunge alla sua mèta: Tangeri. La funzione del paesaggio è spesso fondamentale in Duvivier. Noi ricordiamo la gita in campagna col padrino come la pagina più bella di PeI di carota: è una pagina intima, sua, dove si stacca dal romanzo: la letteratura non ha più peso: sentiamo la schiettezza dell’ispirazione artistica. Qui non ha neppur bisogno di soccorrere l’astuta tecnica fotografica; posti semplici vogliono semplicità di mezzi: e questi scorci paesani debbono essere molto vicini allo spirito e al cuore di Duvivier”. (Ugo Casiraghi, Bianco & Nero, n.12, 1939).