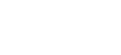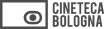CALVARIO
F.: Giovanni Vitrotti; Int.: Lydia De Roberti (Enrichetta Dupuis), Ubaldo Maria Del Colle (Conte Valery); Prod.: Pasquali 35mm. L. or.: 950 m. L.: 833 m. D.: 40’ a 18 f/s. Bn.
Scheda Film
Calvario, con i suoi 950 m. di lunghezza è il primo lungometraggio prodotto dalla Pasquali, che lo pubblicizza esplicitamente come “dramma passionale moderno”. In effetti il film mostra molti caratteri di modernità che giustificano la frase di lancio. Il dramma di una donna virtuosa (Lydia De Roberti) tradita e brutalizzata dal marito (Ubaldo Maria Del Colle) ha come sfondo il frenetico e infido scenario della città moderna, implicitamente identificato come luogo di perdizione, palcoscenico ideale di incalliti giocatori d’azzardo, di adulteri impenitenti, di amanti senza scrupoli. Un ambiente urbano cinico e dissoluto che i realizzatori di Calvario plasmano sul modello dei film “sensazionali” prodotti in Danimarca e accolti con grande favore nelle sale italiane. Di particolare interesse la prova di Lydia De Roberti, che con la sua recitazione intensa, dagli accenti melodrammatici marcati si impone in scena con grande personalità. La stampa non mancherà di sottolineare le doti mostrate dall’attrice in questo film. La drammatizzazione del gesto, l’espressione del volto, lo strazio, lo spasimo, l’angoscia dell’anima: un vocabolario dedicato all’interpretazione della De Roberti che diventerà usuale qualche anno più tardi nelle recensioni riservate ai diva-film di cui Calvario è forse una primordiale anteprima.
Giovanni Lasi
Nell’autunno del 1911, Victorin Jasset pubblica sul Ciné-Journal una storia della produzione cinematografica e del «ciné» dagli inizi nel 1898. Osserva come nel 1906 sono uscite le prime “scènes sentimentales”, tra cui La Loi du pardon (il film sarà presentato all’interno della rassegna su Capellani), che “avrà un enorme successo… la via è stata indicata”. Jasset si dedica poi alla recitazione, che all’epoca non aveva particolare rilievo: “Il prologo della scena si raccontava rapidamente, il più rapidamente possibile, e poi l‘azione. Non si poteva perdere tempo su minuzie come la costruzione del personaggio o sfumature d’espressione”. I lungometraggi del 1911 non sono tutti lunghi alla stessa maniera: alcuni sono cresciuti verso l’esterno ed hanno sviluppato una trama più corposa – vale per il genere di Jasset, il poliziesco. Altri sono, per così dire, cresciuti verso l’interno, e la trama non è più sostanziosa che in un corto: nell’accresciuta lunghezza trovano spazio stati d’animo ed emozioni, sguardi, pose e sfumature sulle facce che esprimono lo stato d’animo dei personaggi. Ekspeditricen è un meraviglioso esempio di questa dimensione emozionale; e si capisce che al pubblico cominciasse a piacere questa nuova forma espressiva. Svariate sono però le opinioni sul lungometraggio: un prezioso testimone è il corto Ein Augenblick im Paradies, in cui gli artisti del varietà si prendono gioco del film lungo. Lene Land fa una parodia della Nielsen e della sua interpretazione nel film In dem grossen Augenblick, che diventa Tonbild: Der Schrei nach dem Kind [Sonoro: l’urlo al bambino]. Persino le didascalie sono una presa in giro e annunciano un film che dura un’ora e mezza. Anche il pubblico non è sempre e solo entusiasta: “Per molti il bello del cinema finisce con il passaggio dalle corte scene drammatiche al lungometraggio. Non è più la stessa cosa. Non c’è più l’onnicomprensivo programma variopinto, che Grosz rimpiangeva nel 1931: “Che programmi che c’erano, duravano ore…normalmente 20 numeri, ingresso 10 o 20 Pfennig… Strano, prima andavo molto più spesso al cinema”. “I corti non dovrebbero essere il pre-programma, ma il programma. Il cinema d’anteguerra era più vario”. (Fritz Güttinger, Der Stummfilm im Zitat der Zeit, 1984, p. 63)