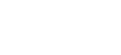Matarazzo. Romanzi popolari

…Je suis très heureux que vous consacriez cet ensemble a Matarazzo, que je considère, depuis très longtemps, comme le plus grand metteur en scène italien
Jacques Lourcelles, maggio 2007
Che straordinario risarcimento sarebbero state queste parole per Raffaello Matarazzo, negletto maestro del cinema popolare italiano, trionfante presso le platee degli anni Cinquanta, trascurato o vituperato dalla critica coeva di qualsiasi declinazione ideologica, recuperato da una certa ribalda brigata negli anni Settanta, per qualche anno rilanciato e triturato dalla exploitation televisiva, e di nuovo scivolato in un condiscendente oblio. Cineasta delle dolenti passioni carnali, delle voluttuose espiazioni, dei salvifici ritorni all’ordine, Matarazzo s’affaccia al cinema negli anni Trenta dei Camerini e dei Blasetti, dei ‘telefoni bianchi’ e dei registi con gli stivali: lui, invece, è “il regista che si toglieva il cappello davanti alle generiche” (Tatti Sanguineti), un uomo tranquillo, un signore gentile nel suo pingue profilo hitchockiano, “il più intelligente di noi tutti, di vera cultura, un crociano autentico” racconterà Riccardo Freda a Francesco Savio, “solo vittima della propria paralizzante paura di tutto”. Sì, Matarazzo aveva paura, paura di morire e paura di sbagliare, era l’uomo dei tormentosi ripensamenti, eppure con quanta concreta audacia si butta nel cinema di regime: Treno popolare è l’esordio di un ventitreenne che fa saltare ogni prescrizione propagandistica perché ha visto e assimilato il lirismo espressionista di Menschen am Sonntag (Uomini di domenica), perché respira con gioia l’avanguardia, perché ha un senso della mise-en-scène ‘realista’ che anticipa certe vocianti domeniche d’agosto, ma anche la desolata dolcezza d’una partie de campagne. Il film, bellissimo, non piace a nessuno, Matarazzo va avanti, diventa regista di commedie talora scritte da Aldo De Benedetti, talora interpretate dai De Filippo, discretamente accolte ma incapaci di conferire al loro autore una fisionomia, nemmeno quando, com’è il caso di Giorno di nozze e L’avventuriera del piano di sopra, mostrano intuitiva sintonia con il rimario della miglior commedia romantica internazionale. È l’incontro con Goffredo Lombardo e la Titanus a plasmare il controverso mito: nel 1950, Catene risulta un così risonante successo di profondità (ovvero, soprattutto delle sale di province e periferie) da incatenare il regista al proprio destino mélo. È qui che invece la critica si scatena, rigida e superciliosa da sinistra, selvaggiamente strafottente se a firmarla è un letterato come Giuseppe Marotta. Eppure che cosa sono queste catene se non le nostre nazionali catene della colpa, in un film che comincia con i tempi e le luci e i sospetti d’un noir per tessere poi la trama della tentazione e del fiero sacrificio femminile, come nella tarda evoluzione di un’Assunta Spina? Ci vorranno, in Italia, quelli della brigata savonese del 1976 (Aprà Freccero Grmek Germani Grasso Lombezzi Pistagnesi Sanguineti) per dichiarare a viso aperto che quei film “arcaici e reazionari erano anche inequivocabilmente belli”. Un passo ancora oltre gli anni Settanta, e si dovrà riconoscere che ‘arcaico’ vale archetipico, e ‘reazionario’ andrà perlomeno colorito d’ironia, se è vero che pochi di questi “lacrimogeni” mélo ottengono l’approvazione del Centro Cattolico Cinematografico: se il loro perimetro narrativo resta la famiglia infine conciliata (ma con quali perverse torsioni, almeno in I figli di nessuno, nell’Angelo bianco, in Guai ai vinti!), la loro ragion d’essere profonda è “l’anelito passionale” (Sergio Grmek Germani), la portentosa creazione di un mondo d’impuro sentimento, dominato dalla totemica Madonna di Yvonne Sanson, peccatrice e martire. In Francia Jacques Lourcelles, il primo (“Présence du cinéma”, 1966), il più acceso, il più autorevole dei matarazziani, avrebbe poi scritto nel suo Dictionnaire pagine luminose qui di seguito in parte riportate, e che ancora costituiscono il miglior passaporto per avvicinarsi alla retrospettiva che vi proponiamo.
Raffaello Matarazzo sapeva comporre l’inquadratura, sapeva dirigere gli attori, sapeva trattare le generiche, sapeva far ridere e molto di più far piangere, sapeva condurre il suo “neorealismo d’appendice” fino all’apoteosi e alla deriva (L’angelo bianco, sfrenata fantasia doppelgänger…), poiché non ne dimenticava la consolante, eccitante natura di finzione. Nella sua Risaia, una meravigliosa mannequin come Elsa Martinelli, con la sua aria da studentessa del Quartiere Latino, può essere la mondina d’una padania Cinemascope e Ferraniacolor. In Malinconico autunno, film minore e già in exitu, Amedeo Nazzari, capitano di mare che si prende cura della ragazza madre Sanson e del di lei bambino, pronuncia la frase: “Sono un finto padre, dunque ti porto un finto albero di Natale”. Sfrontato patetismo, ironia crudele o vera profondità teorica? Raffaello Matarazzo, l’uomo che si toglieva il cappello, aveva, come solo i migliori, un’idea del mondo e un’idea del cinema.
Paola Cristalli