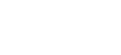TROUBLE IN PARADISE
Sog.: dalla pièce The Honest Finder di László Aladár. Scen.: Samson Raphaelson. F.: Victor Milner. Scgf.: Hans Dreier. Mus.: W. Franke Harling. Int.: Miriam Hopkins (Lily), Kay Francis (Mariette Colet), Herbert Marshall (Gaston ‘LaValle’ Monescu), Charlie Ruggles (il maggiore), Edward Everett Horton (François Fileba), C. Aubrey Smit (Adolphe J. Giron), Robert Greig (Jacques). Prod.: Ernst Lubitsch per Paramount. 35mm. D.: 81’. Bn
Scheda Film
Lubitsch talks. Non per la prima volta (ci sono stati i couplets canterini di Il principe consorte e Un’ora d’amore, e c’è stato Broken Lullaby). Ma con Trouble in Paradise Lubitsch chiede alla parola tutto ciò che la parola può dare al suo sofisticato sguardo sul cinema e sul mondo. Parola levigata, sgusciante, firmata Samson Raphaelson (un sodalizio leggendario), alla quale dobbiamo prestare ascolto veloce e cooperativo, lasciando che poi l’eco d’ogni allusione depositi il suo brivido o la sua cenere sui destini che ci vengono lasciati immaginare. La posta in gioco è un’intravvista o rimandata o già perduta promessa erotica: “Lei non sa cosa si perde” dice andandosene Herbert Marshall, un Monsieur LaValle smascherato e tornato ad essere Gaston Monescu, ladro d’alto bordo; “Oh, sì, lo so”, mormora Kay Francis, e certo non sta pensando ai casti valzer che avrebbe ancora sognato una Jeannette MacDonald; “Oh no, madame, lei non lo sa”, ribatte lui con infinita malinconia, sfilandosi di tasca la lunga collana di perle che le ha appena sottratto. Commedia di parole sbilanciate al di là di se stesse, con un sapore d’aforisma wildiano (l’importanza di chiamarsi Ernst…?) sciolto nella fluidità del dialogo, Trouble in Paradise è altresì il trionfo dell’immagine autosufficiente. Dissolvenze su un orologio, dettaglio sullo scatto d’una chiave che gira. Uno specchio riflette un abbraccio clandestino, due ombre s’accostano sul satin candido di un letto. Interni sovradimensionati, vertiginosi, un plein air déco con il quale lo scenografo Hans Dreier fonda il canone della commedia sofisticata, che altri declineranno senza attingere né cercare lo stesso grado di astrazione concettuale. Assolutamente moderna, questa commedia pre-Hays di sensi doppi e di tripli giochi (una riedizione del film, tre anni dopo, non passerà il vaglio di un Codice ormai stabilizzato) non conosce retoriche crepuscolari (la felicità perduta, le rose non colte). Il reciproco borseggiarsi di Miriam Hopkins e Herbert Marshall, sfida ludica che apre e chiude il film, è l’unico approdo che si concede il romanticismo lubitschiano, troppo rarefatto per essere struggente: “la commistione irresistibile tra erotismo e furto” (Guido Fink), l’allusione a come, fuori o dentro il paradiso, farsi ladri l’uno dell’altro rientri tra le strategie fondanti dell’amore. Certo dietro qualcosa rimane; resta un’ombra, un languore, una scia profumata (e Kay Francis, più bella di Miriam Hopkins, è bella come può esser bello un fantasma). Ma il gioco può senz’altro ricominciare, anche se “sul piano dello stile, non ho mai più fatto nulla che superasse o nemmeno eguagliasse Trouble in Paradise” (Ernst Lubitsch).
Paola Cristalli